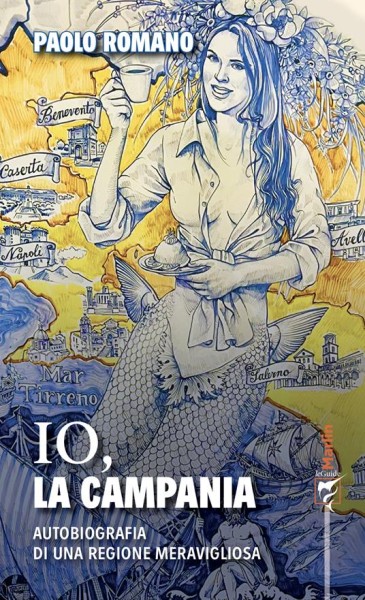
Paolo Romano
Io, la Campania
Autobiografia di una regione meravigliosa
Descrizione
Dalle prime popolazioni italiche ai giorni nostri.
Preistoria, storia, cultura, arte, turismo, enogastronomia, tradizioni. Per la
prima volta, in una narrazione emozionante e coinvolgente, una delle regioni
più belle del mondo "si racconta" in prima persona. In un progetto
originale, la Campania diventa una donna che dice di sé nella forma
dell'autobiografia, aprendosi a ventaglio a tutte e cinque le sue province,
considerate come altrettante figlie della propria famiglia. La forma diretta
attraversa diversi registri: colto, divulgativo, storico, poetico, persino
ironico. Non la solita guida, ma il memoir di una regione che è sintesi e icona
dell'intero Mezzogiorno d'Italia; non un resoconto storico-turistico, ma il
racconto diacronico e curioso di una terra antica. È l'autoritratto che
illustra il profilo più autentico della Campania, offerto al lettore come
l'affresco narrativo di una figura femminile fascinosa.
L'Autore
Paolo Romano è giornalista, scrittore, docente di Italiano, Storia e Geografia. Ha realizzato documentari culturali in India, Tunisia, Germania, Israele, Egitto e Giordania. Con il filmato Sulle orme di Cristo in Terra Santa ha vinto il 60° Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Ha collaborato con la Rai e i quotidiani Il Corriere di Salerno, Il Mattino, La Città. È redattore dell’emittente televisiva Tds, collabora con il Quotidiano del Sud. Ha curato i volumi: Mille quadri non dipinti, con prefazione di Erri De Luca; La ricostruzione della memoria – A vent’anni dal terremoto e Salerno in cartolina. Le sue poesie sono state tradotte negli Stati Uniti, sul numero 45 della rivista “Gradiva – International Journal of Italian Poetry”. Per Typimedia è il curatore dei volumi La Storia di Salerno e La Storia del coronavirus a Salerno.
Leggi il primo capitolo
1.
Che
fisico!
1.1 Una regione fichissima
Una
terra vantata come una pianura ma molto montuosa, poche isole ma di infinita
bellezza, pochi fiumi ma densi di storia, un vulcano che ha regalato al mondo
il più grande tesoro del mondo antico, un altro sommerso, covato sott’acqua
come un grande calderone pronto a esplodere, una costa lunga, frastagliata,
ricca di golfi, baie, seni, cale e calette, scogli e grotte naturali; borghi
unici al mondo, che si arrampicano sulla roccia per regalare dimore simili a
nidi di rondini, nello scenario pittoresco di una costa ormai inscindibile
dall’aggettivo divina.
Poi,
a sud, un’altra costa, aspra e selvaggia, brada come una mandria di cavalli di
mare, come perduta nel tempo, tra ulivi e genti centenarie. Potrebbe essere
solo una prosa poetica, invece è la mia terra. Una terra fertile e felice, un
piccolo paradiso dove vivere nell’ozio e contemplare la bellezza del paesaggio,
un clima mite che quasi non conosce i rigori dell’inverno. Ma anche le zone
interne, con i miei Appennini, i borghi più isolati, i paesaggi agricoli, i
dolci declivi, i frutteti, i boschi e i vigneti non sono da meno. Mi piace
ritrarmi così, nel profilo sintetico, nella bellezza del mio corpo antico. Ma
la geografia ha le sue leggi e allora occorre ricordarle.
1.2 I monti. Anche io ho le dolomiti!
Solo
il 15% della mia superficie è costituita da pianure, per il restante 34% da
montagne e per il 51% da colline. Verso l’interno, la mia spina dorsale è
costituita dagli Appennini: quello Sannita, quello Campano e quello Lucano. A
dispetto di quanto creduto da molti, la mia montagna più alta non è il Cervati
(1899 metri), che si erge nell’Appennino Lucano, nel cuore del Parco del
Cilento Vallo di Diano e Alburni, ma La Gallinola, la cui cima è al confine con
il Molise ed è alta 1923 metri. Poi ci sarebbe il monte Miletto, che con i suoi
2050 metri è ancora più alto, ma la cima è in Molise, sebbene si estenda fin
nella provincia casertana. Nei vecchi libri di geografia è dato ancora come il
più alto. A sud di Salerno ci sono i Monti Alburni detti “Le Dolomiti del Sud”,
che hanno una loro aspra e monumentale bellezza, soprattutto quando le cime
rocciose si colorano con diverse sfumature di rosa e il tramonto dimostra di
essere meraviglioso anche sulle vette che scrutano il cielo. Il Monte Panormo
(1742 metri), nel comune di Ottati, è la vetta più alta ed è conosciuto anche
come “Monte Alburno”. Se volete raggiungerne la cima, il sentiero si inerpica
da Sicignano degli Alburni. Va ricordato anche il Monte Gelbison (1704 metri),
quarta vetta più alta del Cilento. Il nome è di origini arabe e significa
“montagna sacra”, perché tale è sempre stata, dalle antiche popolazioni degli
Enotri ai cristiani che vi hanno costruito il Santuario mariano più alto
d’Italia, ancora oggi meta di pellegrinaggi compiuti a piedi lungo i sentieri
che si inerpicano sui fianchi della montagna. Dalla cima si può ammirare un
panorama incredibile che abbraccia dal golfo di Policastro alla piana del Sele.
Quando non c’è foschia e il vento ha spazzato le nubi, si possono intravedere la
costiera Amalfitana, con le isole di Capri e Ischia e, ancora oltre, il lontano
arcipelago delle Eolie con Stromboli.
1.3 I fiumi dove scorre la Storia
Il
fiume Garigliano scorre lungo il confine con il Lazio e termina il suo corso
nel golfo di Gaeta. L’Ofanto nasce in Irpinia ed è l’unico mio fiume a sfociare
sul versante opposto, nel Mare Adriatico. Dall’Appennino Campano discendono due
fiumi importanti: il Volturno e il Sele, proprio perché grandi e antichi danno
luogo alle omonime due pianure principali. Per il resto sono una regione “di
rilievo”, cioè prevalentemente montuosa e collinare, considerando l’ampio
spazio occupato dagli Appennini, che mi attraversano da nord a sud come una
spina dorsale. Il fiume numero uno è il Volturno, che nasce in Molise, tra i
monti della provincia di Isernia, attraversa le province di Benevento e
Caserta, bagna Capua e sfocia a Castel Volturno, nel golfo di Gaeta, sul
Tirreno, dopo aver percorso la bellezza di 175 km ed essersi ingrandito con le
acque del suo affluente Calore. Durante le piene diventa un fiume impetuoso e
rapido, tanto che i Romani lo hanno soprannominato “Volturnus celer” ed è
citato da Virgilio, Ovidio, Lucano e Claudiano. Volturno era una divinità
etrusca, che i Romani introdussero nel loro Pantheon, come una sorta di dio del
mutamento, impetuoso e repentino. Un dio di cui sappiamo poco, salvo che è
legato all’omonimo corso fluviale.
Accanto
alla foce del Volturno, Domiziano fece costruire un ponte quando realizzò la
Via Domitia che conduceva a Cuma. Quell’evento è ricordato da Stazio: il poeta
napoletano dell’antica Roma ne scrive nel suo carme celebrativo Via Domiziana,
dando voce al fiume che si esprime in prima persona. Intendiamoci: nulla a che
vedere con la mia autobiografia, solo un voler far parlare il corso d’acqua per
fini encomiastici: “Ma il Volturno col suo biondo capo e la sua umida chioma
per largo tratto coperti da umide erbe palustri leva il suo volto e, appoggiato
all’immenso arco del ponte di Cesare, emette dalle sue rauche fauci tali
parole: ‘O tu che con grande bontà dai incremento alle mie campagne e mi hai
legato al regime di un regolare letto, mentre andavo dilagando per impervie
valli, ignaro di cosa significhi scorrere fra due rive, ecco che ora io, da
torbido e minaccioso che ero, che prima a mala pena sopportavo il passaggio di
malsicure imbarcazioni, porto oramai un ponte e sono traversabile a piedi; io
che ero abituato a travolgere zolle di terra e me ne vergogno a trascinar via
tronchi d’albero, ho cominciato ad essere un vero fiume’”. Devo riconoscere
che, per la posizione importante che occupa nelle mie terre e le fertili
pianure che attraversa in tutta la loro estensione, dagli Appennini al mare, il
Volturno è un fiume che ha giocato un ruolo importante nella mia storia e in
quella d’Italia. A cominciare dalle guerre dei Romani coi Campani e i Sanniti,
poi durante la Seconda Guerra Punica e ancora nel Risorgimento, quando sulle
sue sponde si combatté una decisiva battaglia tra i garibaldini e l’esercito
borbonico di Francesco II. Su quell’epico scontro, Giuseppe Cesare Abba, che
combatté con le camicie rosse, scrisse il fortunato libro Da Quarto al Volturno
– noterelle di uno dei mille. Vi si legge: “Qua, a sinistra, tra quelle gole di
Castel Morrone, il maggior Bronzetti, con un mezzo battaglione, tenne la
stretta contro i borbonici, sei volte più numerosi dei suoi. Morì, morirono, ma
il nemico non poté passare”. In effetti, ci furono gesti di eroismo da una
parte e dall’altra del fronte, ed è bello constatare che i rapporti redatti dai
garibaldini vincitori coincidono con quelli dei borbonici, ed entrambi lodano
anche il valore del nemico. Le rive del Volturno saranno poi teatro di un altro
aspro scontro durante la Seconda guerra mondiale, con l’avanzata degli Alleati verso
nord e i tedeschi impegnati a frenarli. Prima di stabilizzarsi sulla linea
Gustav, il confine immaginario scelto dal generale Kesserling nel punto più
stretto dell’Italia (tra Minturno sul Tirreno e Ortona sull’Adriatico, passando
per gli Appennini), è stato il Volturno il primo ponte difensivo dei tedeschi.
La battaglia lungo le fangose sponde del fiume durò almeno tre giorni, dal 12
al 14 ottobre 1943. Gli Alleati lanciarono granate e fumogeni nell’acqua,
tentando di ridurre la visibilità e consentire ai soldati di attraversare il
fiume con canotti e piccoli battelli. Gli uomini di Hitler si asserragliarono
sulle colline dell’altra sponda, sottoponendo il nemico a un fuoco incrociato
di proiettili di mitragliatrice e concentrandosi tra le case di Caiazzo
(Caserta). Prima di ritirarsi, le truppe di Kesserling saccheggiarono,
incendiarono il borgo e uccisero molti civili. La cittadina ha ricevuto poi la
Medaglia d’argento al merito civile per le feroci rappresaglie da parte delle
truppe naziste e un devastante bombardamento dell’esercito alleato che
causarono la morte di numerosi concittadini, tra cui donne e bambini.
Nel
Volturno fa confluire le sue acque il fiume Calore, che nasce dal Cervati, il
mio secondo monte più alto. Il nome deriva, ovviamente, dalla temperatura delle
sue acque, un po’ più alta della media. Per gli appassionati della pesca,
dobbiamo dire che è ricco di trote. Il suo percorso di 108 km è tra i più belli
dal punto di vista naturalistico: boschi incontaminati, gole, cascate, ruscelli,
oasi che sembrano dipinte da un pittore. Spettacolari le “gole” che il Calore
ha formato tra Felitto e Magliano, scavando nel corso di millenni cinque grandi
canyon attraverso le pareti rocciose. Un paesaggio che raggiunge l’apice della
bellezza in località Remolino, dove ci sono le cosiddette “Marmitte dei
Giganti”, enormi pozzi nella roccia, formati dall’azione instancabile
dell’acqua e della corrente. Lungo le Gole del Calore e nelle aree attrezzate
del Remolino si possono vivere momenti liberi nella natura incontaminata, fare
il bagno nelle acque cristalline, risalire il corso fluviale in pedalò o in
canoa, fare trekking o praticare il “torrentismo”, ovvero una discesa a corpo
libero nelle acque del fiume, muniti di casco e giubbotto salvagente, che consente
di avventurarsi anche negli anfratti e nei posti più impervi, solitamente non
percorribili in canoa.
Il
fiume Sele, invece, divide quasi in due la provincia di Salerno e sfocia a
Paestum, dopo aver attraversato la grande pianura che ha contribuito a creare
dandole il nome. È lungo 64 km e nasce in prossimità del Monte Cervialto, a
Caposele, in provincia di Avellino. Dopo aver superato Contursi Terme vi si
immettono le acque di un importante affluente, il fiume Tanagro, quindi
converge nella piana di Paestum e riceve il fiume Calore. Letteralmente il Sele
dà da bere all’assetata regione pugliese, grazie all’acquedotto omonimo che ne
capta le acque nei pressi di Caposele. Gli antichi Greci lo chiamarono
“Silarus” e fecero propria la leggenda secondo la quale immergendo nelle sue
acque un ramoscello di legno esso si trasformerebbe in pietra. La credenza è
supportata da Strabone, secondo il quale i ramoscelli calati lungo le sue
sponde sassificano in pochi minuti, pur conservando forma e colore. A indurre
la visione magica è la forte presenza di carbonato di calcio nelle acque del
mio corso fluviale. Inutile dire che un tempo il fiume era navigabile e
ampiamente sfruttato come via di comunicazione.
È
sempre Strabone che riferisce di una fondazione mitica sul tratto finale del
fiume. Presso la foce del Sele, Giasone e gli Argonauti, di ritorno
dall’impresa della conquista del vello d’oro, costruirono un tempio dedicato
alla dea Era. Grande la felicità degli archeologi Paola Zancani-Montuoro e
Umberto Zanotti-Bianco, che durante gli scavi del 1935 portarono alla luce i
resti dell’Heraion. Fino ai primi del Novecento, il fiume ha formato vaste zone
paludose, che interessavano anche l’area dei templi, prima di essere poi
sottoposta a una lunga e impegnativa azione di bonifica. Nella Piana del Sele
oggi c’è un’intensa attività agricola, con migliaia di serre per la produzione
di pomodori, fragole, fiori. Talvolta, quando la si guarda dalle alture, la
vasta distesa di serre riluce al sole ingannando la vista e dando l’impressione
che si tratti della distesa marina.
Il
fiume Sarno non è molto lungo, appena 24 km. Ma è enorme il suo bacino,
parliamo di un’area di oltre 500 km quadrati, per giunta densamente popolata,
denominata appunto piana dell’agro nocerino-sarnese. Riceve le acque di due
torrenti principali (Solofrana e Cavaiola) e di circa una sessantina di
affluenti minori, centocinquanta torrenti e valloni. Fanno parte del suo bacino
fossi, controfossi e diciotto vasche di compensazione. Di questa abbondanza irrigua
non poteva non avvantaggiarsi l’agricoltura, in una terra già di per sé fertile
per la vicinanza del Vesuvio.
In
epoca antica Sarno era venerato come un dio. A Pompei è stato rinvenuto un
affresco romano che lo raffigura nella classica posa delle divinità fluviali,
come il Tevere e l’Arno, ovvero come un gigante barbuto, sdraiato su un fianco,
che regge una giara da cui sgorga perennemente l’acqua che alimenta il fiume.
Intorno a lui canne e papiri. Fino ai primi del Novecento era navigabile, la stessa
città di Scafati che attraversa deve il suo toponimo agli “scafi” che servivano
per muoversi agevolmente tra i cento canali di una piccola Venezia agricola.
Oggi vanta il triste primato di fiume più inquinato d’Europa, per via degli
scarichi industriali che riceve lungo il suo percorso.
Ma
alla foce, a nord-ovest della città di Sarno, l’acqua è ancora limpida e
cristallina, tanto che la Pro-Loco di Sarno, oggi guidata da Vincenzo Cerrato,
sta portando avanti un originale progetto di valorizzazione turistica centrato
sulla “Città delle acque”. Così la conobbero i Sarrasti, primi abitanti italici
del comprensorio menzionati da Virgilio nell’Eneide. Nel IV secolo a.C., prima
della colonizzazione romana vi costruirono un santuario: abluzioni, pratiche di
iniziazione, passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta, l’acqua era
funzionale ai riti religiosi. I Sarrasti realizzarono una sorta di Venezia
protostorica, tanti villaggi costruiti su isolotti e raggiungibili attraverso
canali navigabili. Centinaia di statuette votive ritrovate in loco raffigurano
donne che partoriscono, allattano e portano bambini in grembo. Testimoniano il
culto di una imprecisata divinità femminile legata alla fecondità della natura
e delle donne. Nello stesso sito c’è una vasta area archeologica, con un teatro
ellenistico-romano del II secolo a.C., con le gradinate che sfruttano la
naturale pendenza di una collinetta. Oggi come allora, i posti migliori erano
riservati alle autorità ed erano scolpiti in tufo, con particolari decorazioni
e fregi. L’intera area archeologica è immersa in un bellissimo scenario
naturale, il Parco fluviale “Cinque sensi”, dove lo scrosciare dell’acqua e il
fluire delle fonti, come millenni fa, contribuisce a definire una sorta di
colonna sonora dell’anima.
Non
poteva mancare il riferimento cristiano con il santuario di Santa Maria della
Foce, dove c’è la tomba di Gualtiero di Brienne, valoroso e devoto cavaliere
francese medievale. Si racconta che San Francesco d’Assisi sia passato di qui
per rendergli onore e pregare. Nel 2003 è nato il Parco regionale del Fiume
Sarno, per valorizzare il percorso fluviale e il patrimonio storico, culturale,
ambientale e archeologico di un territorio molto esteso.
1.4 L’azzurro mare etrusco
E
ora parliamo del mio celebre mare, il Tirreno. Prende il nome dall’appellativo
“Tirreni”, con il quale i Greci chiamavano gli Etruschi, quindi lo si può
propriamente definire “il mare etrusco”. I Romani, infatti, lo indicavano come
“Mare Tuscum”. È il più vasto del Mediterraneo, e anche uno dei più profondi
(fino a 3500 metri), nonché tra i più salati del Mare Nostrum: parliamo di una
salinità del 38‰, che aumenta ancor di più in profondità. Nei suoi fondali si
ergono, a grappolo, montagne vulcaniche. Molti non sanno, per esempio, che
Palinuro è anche un vulcano sommerso, situato al largo del Golfo di Policastro.
Poi c’è il temibile Marsili, a 150 km a sud di Napoli, che è il più grande
vulcano sottomarino dell’intera Europa: se dovesse entrare in azione sarebbe
una catastrofe, non tanto per l’eruzione in sé, quanto per il maremoto che
provocherebbe. Di un mare si possono misurare i colori e la zona di Capri è tra
le più trasparenti del vasto bacino Mediterraneo. A superarne la natura
cristallina e azzurra è soltanto l’isola di Rodi, nel mare greco. Quattro sono
i golfi che si affacciano sul Tirreno: il golfo di Gaeta, condiviso con il
Lazio; il golfo di Napoli; il golfo di Salerno, il più grande, “Il lunato
golfo”, come ebbe a definirlo il poeta Gabriele D’Annunzio, e il golfo di
Policastro, condiviso con la Calabria.
Le
coste dei golfi di Gaeta e Salerno sono basse perché alle loro spalle si aprono
due grandi pianure alluvionali, mentre quelle che si affacciano su parte del
golfo di Napoli, sulla penisola sorrentina e amalfitana e nel Cilento, dove le
colline si spingono fin quasi dentro l’acqua, si presentano spesso alte e
rocciose. Sono proprio queste caratteristiche, come vedremo, a rendere uniche
al mondo le mie costiere, mete turistiche di interesse internazionale.
1.5 Isole nella corrente
E
veniamo alle mie isole, che sembrano scogli per supportare i passi di un
gigante che camminano sul mare. Procida e Ischia sono di natura vulcanica, uno
sputo di lava conficcatosi in acqua, lapilli di incomparabile bellezza che il
fuoco della terra ha depositato tra i flutti per ancorarvi atolli mediterranei.
Procida è l’icona di un Mediterraneo policromo, con le case di Marina
Corricella che i pescatori hanno dipinto di diversi colori pastello per poterle
facilmente riconoscere da lontano. Come a far proprio il detto latino che
Plutarco attribuisce a Pompeo e che D’Annunzio riprende nelle sue laudi –
“navigare è necessario, vivere non è necessario” – molti procidani sono
imbarcati sulle navi mercantili e da crociera, dove spesso raggiungono i più
alti gradi marinari, mantenendo viva una vocazione antica degli abitanti
dell’isola.
Capitale
italiana della Cultura 2022 con lo slogan “la cultura non isola”, Procida è lo
scenario selvaggio in cui la scrittrice Elsa Morante ha ambientato L’isola di
Arturo, il romanzo vincitore del Premio Strega nel 1957. Come uno scugnizzo di
mare, il protagonista Arturo vive scalzo, visitando ogni giorno la costa, gli
scogli, la spiaggia, immerso nelle acque del suo paradiso ma anche nelle
proprie inquietudini, perso nell’orizzonte azzurro come in sogni fantastici.
Nel libro ricorda la sua infanzia e la tormentata giovinezza, in una sorta di
memoriale. Morante sperimentò il fascino dell’isola durante una vacanza d’amore
con Alberto Moravia e volle dargli trasposizione letteraria in un romanzo
intriso di realismo magico, toni fiabeschi e disincantati: un luogo dell’eden
da cui è facile essere cacciati, un paradiso che non tarda a diventare perduto
insieme ai sogni della prima stagione della vita.
Un
secolo prima l’isola stregò anche lo scrittore Alphonse de Lamartine, che nel
1852, durante un viaggio in Italia, visitò Procida e vi ambientò il romanzo
Graziella. Nell’edizione francese il titolo è in italiano, a sottolineare anche
nel nome il riferimento alla fanciulla dalle trecce e dagli occhi neri,
protagonista della vicenda: una ragazza solare e spigliata, che incarna il mito
di un sud incantato e felice, che fa innamorare l’autore proprio per la sua
spontaneità.
A
Procida è nato l’istrionico attore e cantante Peppe Barra, che negli spettacoli
ama ricordare le proprie origini isolane, con la madre Concetta e i racconti
che si facevano intorno al fuoco, nelle sere d’inverno, in una casa a picco sul
mare. Lo stesso mare dove sono state girate alcune scene de Il postino, il film
tratto dal romanzo di Antonio Skàrmeta, in cui Massimo Troisi interpreta il
ruolo di un ingenuo isolano che impara a scrivere versi accanto al grande poeta
cileno Pablo Neruda. Durante le riprese Troisi, malato di cuore, stava già così
male da vedersi costretto a farsi sostituire in bicicletta da una controfigura.
Si può dire, quindi, che l’isola ha rappresentato uno degli ultimi scenari
della sua vita, dove ha rivolto gli ultimi sguardi sulla bellezza del
paesaggio, prima della prematura scomparsa.
La
parte più antica è il borgo Terra Murata, di epoca medievale. È anche la parte
più alta dell’isola, dominata dal cinquecentesco Palazzo d’Avalos, che nel 1830
fu trasformato in un gigantesco carcere a picco sul mare. La vicina Abbazia di
San Michele (del XVI secolo) ospita un pregevole dipinto raffigurante il Santo
che schiaccia il principe del male, Satana.
Collegato
a Procida da un ponte in ferro c’è l’isolotto di Vivara, riserva naturale che
ospita piante rare, conigli selvatici e uccelli acquatici, nonché sito di
grande interesse archeologico per la presenza di testimonianze abitative
micenee. Vivara è ciò che resta di un antico vulcano, la parte emersa del suo
cratere.
È
un cratere che si erge sul mare anche l’isolotto di Nisida, nei Campi Flegrei,
che oggi ospita un carcere minorile.
Ischia
è detta “l’isola verde” ed è la meta ideale per una vacanza di benessere, dove
conciliare mare, sole e bagni termali. Ha rappresentato l’approdo dei primi
Greci in Italia, sbarcati da me prim’ancora che in Sicilia. Oltre a essere una
rinomata località turistica, è l’isola della storia e ve ne parlerò
diffusamente più avanti. È dominata dalla sagoma del Monte Epomeo (788 m),
antichissimo vulcano (la sua ultima eruzione risale al 1302). Nel 1883, invece,
un violento terremoto distrusse l’abitato di Casamicciola; ce ne sono stati
tanti di più recenti ma per fortuna meno disastrosi.
In
uno spazio così limitato posso vantare il record di stabilimenti termali: oltre
centotrenta! L’isola più grande dell’Arcipelago campano si suddivide in una
serie di borghi interni, piccoli comuni ciascuno con attrazioni peculiari.
Ischia Porto, antico cratere vulcanico congiunto al mare da un canale nel 1854;
Ischia Ponte, collegata da un ponte all’isolotto dove sorge il Castello
Aragonese, uno dei punti di riferimento iconici dell’isola. Casamicciola Terme,
con i suoi impianti termali e la Grotta del Turco che merita una visita, come
anche l’osservatorio geofisico e Villa Ibsen. Centro termale è anche Lacco
Ameno, con la pittoresca spiaggia dominata dalla sagoma di uno scoglio a forma
di fungo e l’altrettanto rinomata Baia di San Montano. Forio è più
nell’interno, quasi un angolo di Grecia, con il borgo di case e chiese bianche
di calce, a contrasto del verde dei giardini e dell’azzurro del mare. Da non
perdere una passeggiata tra i viali del Giardino della Mortella, a Forio
d’Ischia: un paradiso di piante mediterranee ed esotiche a strapiombo sul mare.
Fu progettato alla fine degli anni Cinquanta dal paesaggista Russell Page, tra
i maggiori architetti di giardini del Novecento.
Sant’Angelo
è dominata dal suo borgo di pescatori e dalla veduta di un isolotto cui si
congiunge attraverso la spiaggia. Quanto ad arenili quello dei “Maronti”, a
metà tra questo comune e quello di Barano, è sicuramente tra i più famosi: una
lunga striscia di sabbia e una baia tranquilla (il nome deriva dal greco e
significa proprio “spiaggia della pace”). Da Fontana si può salire a piedi al
Monte Epomeo, punto più elevato dell’isola, nel cui nome si vinifica uno dei
bianchi più apprezzati del Mezzogiorno. Ischia è stata terra di vini sin
dall’antichità e il ritrovamento di anfore per l’esportazione della preziosa
bevanda (VI secolo a.C.) ne è la conferma, insieme al rinvenimento dei resti di
impianti di lavorazione vitivinicola.
Capri,
invece, è di natura calcarea e può essere considerata come un prolungamento,
poi spezzato, eroso, della costiera sorrentina. Nonostante le ridotte
dimensioni, è l’isola della mondanità internazionale, con personalità che
giungono da tutto il mondo. Visitatori illustri e semplici turisti convergono
verso quell’ombelico che è “la piazzetta”, centro ideale dell’isola. E se la
vicina costa napoletana di Posillipo rimanda nella radice greca alla “pausa dal
dolore”, così il più esclusivo albergo caprese è un invito alla contemplazione:
“Hotel Quisisana”.
Il
nome suggerisce immediatamente la formula di una salute binaria, che cerca il
benessere del corpo e dello spirito, che nasce dalla bellezza e dalla bontà del
clima e del paesaggio. La struttura ricettiva nacque nella seconda metà
dell’Ottocento come casa di cura esclusiva, dove rimettersi in salute
standosene a riposo in uno dei posti più belli del mondo. Con questo spirito,
per iniziativa del medico inglese George Sidney Smith Clark che si era
innamorato dell’isola e di una bella fanciulla caprese, sorse una prima villa,
che nel 1861 si trasformò nel rinomato Grand Hotel. Qui, in una mega suite,
alloggiava Alfred Krupp. Per poter agevolmente raggiungere il suo panfilo
ormeggiato nella zona di Marina Piccola, a fine Ottocento il magnate tedesco
dell’acciaio fece costruire una strada ad hoc, pagando a sue spese i lavori di
scavo della roccia a strapiombo sul mare. Via Krupp resta una delle vie più
romantiche, impervie e panoramiche al mondo, ma anche molto pericolosa per la
frequente caduta di massi. Un altro albergo, il Capri Tiberio Palace, può
vantare di aver ospitato, nel febbraio 1925, Francis Scott Fitzgerald e la
moglie Zelda. Avvolto nella luce e nell’atmosfera mediterranea della dimora
tirrenica, lo scrittore trovò finalmente la forza e l’ispirazione per terminare
il suo capolavoro, Il Grande Gatsby: è il romanzo forse più esemplare dell’età
del jazz, dove in uno scenario sfavillante di party e vita mondana, il sogno
americano appare incrinato da solitudine e fragilità, nel bel mezzo di un amore
tenero e tormentato.
Prima
di diventare meta mondana, Capri ha rappresentato il rifugio ideale per tanti
perseguitati, è stata – con un gioco di parole – l’isola degli esuli. Vi hanno
soggiornato, tra gli altri, Lenin, Pablo Neruda, Thomas Mann, Filippo Tommaso
Marinetti e su di essa ha aleggiato l’ombra di Tiberio. Così ne fu ammaliato e
stregato il pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913), un po’ santone,
un po’ vate romantico, naturista convinto, anarchico, istrionico. Le sue
immense e metafisiche tele fanno ancora bella mostra di sé nella Certosa di San
Giacomo, mentre la sua visione utopica di una comunità perfetta in simbiosi con
la natura – con l’idea che si possa vivere nudi, nutrendosi di sole sdraiati
sulle rocce capresi – ritorna attraverso le immagini del film di Mario Martone
Capri revolution. C’è l’isola bella e maledetta anche nel caso mai risolto del
suicidio-omicidio di Pamela Reynolds, la poetessa inglese che perse la vita
dall’alto di un dirupo ad appena vent’anni, il 27 maggio 1935. Cadde? Si gettò?
Fu spinta? Certo è che la sua sensibilità tormentata le fece tessere rapporti
con personalità influenti dell’isola, come il sindaco-scrittore Edwin Cerio
(sul caso si legga il libro di Antonio Corbisiero. Il mistero di Pamela
Reynolds).
All’aspetto
dionisiaco di Capri si contrappone quello solare: le immagini dei Faraglioni (i caratteristici
scogli irti dove ancora abita la lucertola azzurra), della piazzetta, di villa
San Michele, di via Krupp e della celebre Grotta Azzurra sono diventate
altrettante icone turistiche in tutto il mondo. Un’isola che mette allegria,
come ha ben detto in versi il poeta russo Vladimir Majakovskij: “Tutti così noiosi,
come se al mondo non ci fosse Capri. Ma Capri esiste. Col suo alone di fiori
tutta l’isola è una donna in una cuffia rosa”. Il controverso intellettuale e
scrittore Curzio Malaparte si fece costruire un’ardita villa su Punta Massullo,
con la celebre e ripidissima scalinata che conduce a una terrazza dove si gode
un panorama mozzafiato. Somiglia a una nave adagiata su uno sperone di roccia,
con la prua affacciata sull’abisso azzurro, a strapiombo sul mar Tirreno. È
isolata, impervia, vi si accede solo attraverso una tortuosa scala intagliata
nella pietra. L’intera struttura architettonica è una sorta di richiamo
metafisico all’infinito. A cominciare dalla terrazza, dove lo scrittore amava
andare in bicicletta nonostante non ci sia il parapetto e il senso di vertigine
è forte. All’interno della dimora grandi finestroni ritagliano il paesaggio,
compreso i Faraglioni che sembrano posizionati all’interno della cornice di un
quadro. A Villa Malaparte il regista francese Jean-Luc Godard girò gran parte
del film Il Disprezzo, tratto da un romanzo di Alberto Moravia. Ne sono
protagonisti due giovani e affascinanti attori: Brigitte Bardot e Michel
Piccoli, alle prese con una storia di separazione e divorzio, nel tema di fondo
dell’incomunicabilità della coppia. Malaparte diceva che “Ischia è Virgilio,
Capri è Omero”, un sogno greco di periplo del Mediterraneo, un’odissea azzurra
dove perdersi con l’anima e il corpo, un sogno infinito di pace e luce.
Anche
il medico svedese Axel Munthe si costruì una dimora sull’isola, conformandola
al suo sentire interiore, arroccata accanto a un’antica cappella: la chiamò
villa San Michele e ne scrisse la storia in un libro, oggi tra i più tradotti e
letti al mondo.
Ad
Anacapri c’è la chiesetta di San Michele, da vedere perché ospita un pavimento
maiolicato unico al mondo: sull’intera superficie del pavimento si staglia un
tappeto ceramico che riproduce il paradiso terrestre e la cacciata di Adamo ed
Eva a seguito del peccato originale. Il serpente si avvolge intorno all’albero della
conoscenza del bene e del male, ma tutto intorno la natura riflette la
perfezione del mondo, con le creature animali di ogni specie che vivono in
armonia e i frutti che crescono copiosi sui rami di un giardino primaverile
perenne. Salendo sulla cantoria della chiesa si può avere una meravigliosa
visione d’insieme del pannello ceramico. Capri è da sempre il rifugio ideale
per artisti e scrittori. Charles Dickens, che giungeva dalla sua fumosa Londra,
ebbe a dire: “In nessun luogo al mondo ci sono tante occasioni di deliziosa
quiete come in questa piccola isola”. Quando il tempo è sereno e non c’è
foschia, da Napoli come da Salerno, i campani della costa usano dire, puntando
lo sguardo all’orizzonte: “Guarda! Si vede Capri”. Pur essendo abituati, la meraviglia
non si attenua, lo stupore si rinnova ogni volta che la sagoma dell’isola
compare in lontananza e nell’azzurro si staglia il suo profilo.
Licosa.
La piccola isola del Cilento, separata dall’omonimo promontorio, prende il nome
dalla sirena che vi è morta secondo la leggenda: il grande scoglio altro non
sarebbe che la sua sepoltura, una sorta di monumento eretto per lei dalla
natura. Sono ancora visibili i resti di un antico insediamento romano, con
vasche per l’allevamento delle murene. Un tempo c’era la casa del guardiano, ne
sono visibili le mura, mentre il faro resta tra i pochi ancora funzionanti
nelle mie terre, per avvisare i naviganti della presenza di insidiose scogliere
e secche. Le acque circostanti sono comprese in una vasta area marina protetta.
Sull’isola è presente una specie endemica di lucertola verde-azzurra e vi
nidifica il gabbiano Corso, specie protetta del Mediterraneo.
Nelle
acque dei miei golfi c’è un susseguirsi di scogli affioranti che segnano il
paesaggio e lo rendono iconico. Soggetti ideali per le cartoline un tempo, e
oggi per foto e selfie. Sono come pietre miliari piantate nel mare, per segnare
le tappe di un cammino marino, sassolini lasciati tra i flutti per ritrovare la
strada del paradiso. Cominciamo da sud con gli scogli di Vietri sul Mare, detti
“I due Fratelli”: al largo di Positano i tre isolotti di Li Galli: Il Gallo
lungo, il cui profilo sembra quello di un delfino, la Castelluccia e la
Rotonda. Segue Capri, coi suoi “Faraglioni”, posti nel mare a guardia dei golfi
di Salerno e Napoli e, verso quest’ultima, Ischia e Procida con il contiguo
isolotto di Vivara.
1.6 Vulcani nascosti
Geologicamente
sono una regione po’ instabile, tra vulcani emersi e sommersi. Il primo
pensiero va, ovviamente, al Vesuvio, vulcano attivo dei più pericolosi, perché
di natura esplosiva. Tutti lo conoscono per la disastrosa eruzione del 79 d.C.
Il cono, così come lo vediamo oggi, si formò allora in seguito allo scoppio del
“tappo” e al crollo di una parte di montagna. Quella pompeiana non fu l’unica
drammatica eruzione. Terribili furono anche quella del 1631, che portò alla
morte di oltre tremila persone e quella del 1794, quando la lava distrusse
Torre del Greco. L’ultima risale al 1944: il gigante si risvegliò mettendo in
ansia la popolazione già duramente colpita dalla Seconda guerra mondiale e i
lapilli arrivarono fino a Salerno. Poi ci sono i Campi Flegrei, ovvero “i campi
del fuoco”, caratterizzati da una enorme caldera, cioè il risultato del
collasso dei coni di grandi vulcani. In tali occasioni, il serbatoio di magma
si è svuotato talmente veloce da far cedere le pareti rocciose del cratere,
dando vita a una gigantesca depressione di forma quasi circolare e dai bordi di
terra poco alti, come un pentolone basso, “Caldera”, infatti, in spagnolo
significa padella. Nei Campi Flegrei questo padellone va dalla collina di
Posillipo a Monte di Procida, con una parte sommersa nel golfo di Pozzuoli.
Secondo alcuni si può parlare di un immenso vulcano sottomarino, anche se per i
vulcanologi il termine non è corretto. L’eruzione più violenta dei Campi
Flegrei è avvenuta 39.000 anni fa e ha sconvolto una vasta regione del
Mediterraneo, oscurando il sole e producendo un abbassamento della temperatura
di almeno 4 gradi.
Il
fenomeno del bradisismo, che porta a notevoli abbassamenti e innalzamenti della
superficie terrestre, interessa ancora oggi la vasta zona dei Campi Flegrei,
soprattutto Pozzuoli. Chiude la lista il vulcano spento di Roccamonfina, in
provincia di Caserta. È un grande cono di circa 25 km di circonferenza alla
base, che si trova tra i monti Aurunci, il fiume Garigliano e il massiccio del
monte Massico. Non è in attività da almeno cinquantamila anni. E speriamo che
rimanga a lungo senza darmi fastidi.
1.7 Le grandi ferite: terremoti e alluvioni
TERREMOTI.
Mi trovo in una zona altamente sismica, fattore questo che di tanto in tanto
porta a scuotermi un po’. In particolare, la dorsale del mio Appennino viene a
trovarsi nella zona rossa, quella con maggiore rischio di terremoti. Si
dimentica, per esempio, che prima ancora dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.,
a distruggere Pompei era stato un terribile terremoto nel 62 d.C. I danni
furano tali che si dovette ricostruire parte della città. Un altro sisma
devastante, tra i maggiori della storia d’Italia, è stato quello del 5 dicembre
1456, che colpì tutta l’Italia centro-meridionale, con una scossa di grado 7.1,
epicentro in Irpinia e danni incalcolabili in tutto il Regno di Napoli. Causò
trentamila vittime tra le mie terre, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la
Basilicata. I danni maggiori furono proprio a Napoli, con migliaia di morti,
crolli di abitazioni e monumenti, come il campanile della basilica di Santa
Chiara e la chiesa di San Domenico Maggiore, poi ricostruita. Un piccolo
tsunami si abbatté sulle coste, distruggendo le barche nel porto della capitale
partenopea. L’ultimo disastroso terremoto è stato quello del 1980, detto
“dell’Irpinia”, anche se interessò diverse province e mi fece del male quasi
ovunque, colpendo pure parte della Basilicata: in novanta interminabili secondi
morirono quasi tremila persone, interi paesi distrutti e una ricostruzione
durata oltre quarant’anni.
ALLUVIONI.
Le alluvioni sono un’altra calamità naturale cui sono soggetta. Nella notte tra
il 25 e 26 ottobre del 1954 su Salerno si abbatté una incredibile bolla
d’acqua, fiumi e torrenti della città strariparono trascinando a valle ogni
cosa, anche corpi umani. Il quartiere Canalone del centro storico fu il più
colpito, come la costiera amalfitana, con Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni,
Maiori, Minori, Tramonti. Le devastazioni furono immense: frane, voragini,
ponti crollati, strade e ferrovie distrutte in più punti, case spazzate via,
scantinati allagati. I danni si calcolarono superiori ai 45 miliardi di lire.
In tutto, fra morti e dispersi, 318 vittime. Poi 250 feriti e circa 5.500
senzatetto. Le vittime furono un centinaio e altrettanti i feriti solo a
Salerno.
Dopo
quella che il poeta Alfonso Gatto definì “la malanotte”, l’Italia intera si
mobilitò in una grande staffetta di solidarietà, a cominciare dal presidente
della Repubblica, Luigi Einaudi, che volle visitarmi nei luoghi interessati
dalla tragedia. Nell’ultimo Novecento, da non dimenticare è l’alluvione di
Sarno, verificatosi tra il 5 e il 6 maggio 1998. Un intero pezzo di montagna,
trascinato dalle acque, franò a valle, colpendo i comuni di Sarno, Quindici,
Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello, i morti furono centosessantuno.
L’anno successivo, papa Giovanni Paolo II, in elicottero, volle sorvolare le
zone colpite di ritorno da Pontecagnano Faiano (Salerno), dove si era recato
per l’inaugurazione del Seminario a lui intitolato. L’ultima, in ordine di
tempo, è l’alluvione che il 9 settembre 2010 interessò Atrani, in Costiera
Amalfitana. L’esondazione del torrente Dragone sommerse in un mare di fango il
piccolo borgo. Francesca Mansi, giovane barista di 25 anni, fu trascinata in
mare dalla violenza delle acque. Il suo corpo fu ritrovato quasi un mese dopo,
il 2 ottobre, al largo delle isole Eolie, tra Panarea e Lipari.
Torna ai libri