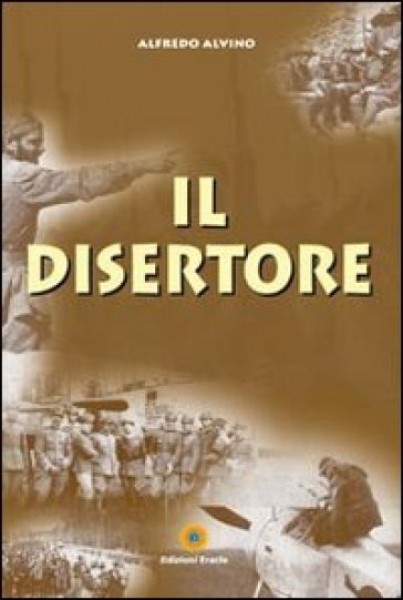
Alfredo Alvino
Il disertore
Premiato con Targa alla XXXV edizione del "Premio Città di Cava de’ Tirreni " anno 2018
Descrizione
E’ la storia, ambientata nella provincia rurale di Napoli tra la fine dell’ottocento ed i primi del novecento, di due giovani: Filuccio e Paolo, della loro amicizia fraterna, dei loro affetti, dei loro amori , delle loro esperienze umane, alcune dolorose, altre più leggere.
Le vicende dei diversi personaggi che ruotano e si intrecciano attorno ai due protagonisti, si svolgono quasi tutte alla “Faragnana”, una verdeggiante zona alle porte di Napoli (oggi denominata Città Giardino), per spostarsi, solo nella parte centrale, nel Nord Italia, teatro del tremendo conflitto mondiale ’ 15-‘18.
Il romanzo si apre con la nascita di Paolo, il figlio maschio tanto atteso da Antonio De Rita, un ex colono diventato, con il suo lavoro, proprietario di una masseria alle porte di Napoli, nella zona chiamata Faragnana, (un tempo detta Foragnano, perchè era una stretta stradina che congiungeva Marano con Agnano).
La nascita di Paolo, rinsalda ancora più i rapporti tra Antonio e il suo vecchio amico Nicola Tortora, (anch’ egli proprietario terriero), che da padrino del bimbo, diventerà un suo secondo padre, specialmente dopo che Antonio rimarrà zoppo a seguito di un brutto incidente di caccia.
A Nicola però verrà riservato dal destino un evento inatteso: la paternità di un figlio maschio concepito fuori dal suo matrimonio, Filuccio. Questo ragazzo diventerà amico fraterno di Paolo ed insieme, da adulti, affronteranno mille pericoli per evitare di essere travolti dalla guerra.
Paolo sposerà, a ridosso del conflitto, Angela, la figlia di Nicola mentre Filuccio si innamorerà perdutamente di Teresa, la figlia del suo datore di lavoro Cosimo Casale, il più ricco dei proprietari terrieri della zona. Questi osteggerà l’amore tra Filuccio e Teresa, con ogni mezzo.
Ma i due giovani dovranno lottare anche contro altri nemici: prima di tutto contro la guerra che porterà a sconvolgere ogni loro sogno, ma anche contro l’amore torbido e malsano del maresciallo Sannino verso Teresa. Un amore che lo spingerà a tradire perfino i suoi principi di uomo di legge integerrimo e lo travolgerà fino alle estreme e terribili conseguenze.
Le storie dei vari personaggi si intersecano tra loro in modo travolgente, da quelli positivi come Antonio, Filuccio, Nicola o Nina ed Angela, a quelli negativi come il Maresciallo Sannino, Carmine o Ninì Casale. Gli amori, le sofferenze, i rischi mortali che i personaggi vivono, si stagliano sullo sfondo di un mondo che non c’è più, e che forse andrebbe recuperato e rivalutato. Paolo e Filuccio sono proprio i rappresentanti di quel mondo semplice e schietto che non può essere dimenticato e soppiantato.
La guerra appare solo sullo sfondo, ma è sufficiente a lasciare i propri segni mortali e deformanti, è la grande guerra, quella terribile e senza scampi, che fece spargere il sangue di migliaia e migliaia di giovani in tutta l’Europa, un mostro famelico pronto a rapire le giovani vite dei due protagonisti.
Entrambi cercheranno di sottrarsi al destino mortale di quella guerra, affrontando quello, forse meno pericoloso ma altrettanto penoso, riservato ad un disertore.
L’idea del romanzo è nata per caso, dopo un incontro avuto con un ultranovantenne, un uomo che amava la sua terra, conoscendone ogni angolo, ogni anfratto, ogni sentiero. Era un uomo che aveva lavorato la terra sin da bambino, ricavandone i frutti migliori. Aveva una mente lucidissima ed una memoria prodigiosa. Mi parlava della caccia, di cui era stato, da giovane, un autentico campione, dei luoghi dove aveva vissuto e che oggi appaiono completamente cambiati dopo una autentica dissennata cementificazione. Ma più di ogni altra cosa mi piaceva sentirgli descrivere la Marano dei primi del novecento, ricca di vegetazione e di luoghi incantati, quando la si attraversava a dorso di mulo o a cavallo, quando il fiume Starza (purtroppo ora sotterraneo e coperto dal cemento) riusciva a dissetare l’intera popolazione allora residente con le sue acque limpidissime che scendevano a valle dalla collina dei Camaldoli. Un giorno però mi raccontò un piccolo aneddoto relativo alla vita di suo padre e di come quest’uomo (anche lui formidabile cacciatore espertissimo e tiratore scelto nell’Esercito) fosse riuscito, con uno stratagemma davvero geniale, ad evitare il fronte e la morte, dandosi alla macchia e riuscendo a non farsi dichiarare disertore.
Un’idea geniale e semplice allo stesso tempo!
L'autore
 Alvino Alfredo, è nato a Napoli nel 1951, è avvocato, ed è autore, del romanzo storico “IL DISERTORE”, col quale ha vinto il premio letterario “IRIDE, CITTA’ CAVA DE’TIRRENI “ ha scritto e pubblicato un altro romanzo storico intitolato “GLI ODORI DEL BOSCO” col quale ha vinto un premio letterario per inediti. Inoltre ha scritto un romanzo breve (non ancora pubblicato) intitolato “LE FIGURINE DELL’ETA’ FELICE“ e di recente ha ultimato e depositato alla SIAE il nuovo romanzo storico intitolato “NEMICI FRATERNI” non ancora edito.
Alvino Alfredo, è nato a Napoli nel 1951, è avvocato, ed è autore, del romanzo storico “IL DISERTORE”, col quale ha vinto il premio letterario “IRIDE, CITTA’ CAVA DE’TIRRENI “ ha scritto e pubblicato un altro romanzo storico intitolato “GLI ODORI DEL BOSCO” col quale ha vinto un premio letterario per inediti. Inoltre ha scritto un romanzo breve (non ancora pubblicato) intitolato “LE FIGURINE DELL’ETA’ FELICE“ e di recente ha ultimato e depositato alla SIAE il nuovo romanzo storico intitolato “NEMICI FRATERNI” non ancora edito.
Di recente ha pubblicato con la Casa Editrice CTL di Livorno il libro “AUTUNNO NAPOLETANO” una raccolta di racconti ambientati tutti a Napoli ed in autunno, peraltro con uno di questi, “IL VICOLO” , ha vinto il premio letterario “I PORTI SEPOLTI”.
Di recente si è anche dedicato al Teatro scrivendo due commedie in vernacolo napoletano: “E’ SIGNURINE BRUSCHETTI” e “A’ MUGLIERA D’O PRESIDENTE”
E’ sposato e vive nella provincia napoletana di Marano.
Leggi il primo capitolo
La tozza massiccia casa colonica appariva silenziosa e un po’ tetra nella grigia alba di quel freddo mattino autunnale del 1892. La casa, che ormai aveva quasi un secolo di vita, sorgeva a metà di una collina alle porte di Napoli, detta “La Faragnana”
L’intera zona, allora, era completamente immersa nel verde della macchia mediterranea; in alcuni punti, dove la vegetazione appariva un po’ meno fitta, le macchie di lentisco, di lecciastrella, di pungitopo e di felci dalle straordinarie dimensioni e dal colore verde intenso, specie in primavera, venivano interrotte dal rosso dei papaveri, dal bianco dei fiori di mirto o dal ridente giallo delle ginestre. Dove, invece, la vegetazione era più fitta, il forteto diventava a tratti inestricabile; era il trionfo della selva, quella che chiamavano “A’ Recca”, lì vi abbondavano querce, faggi, pioppi e noci secolari, intervallati, a tratti, da pini altissimi e frondosi. Era questo il regno della selvaggina dove non di rado, fra le diverse specie di volatili, era possibile incontrare, negli stretti sentieri del bosco, volpi, lepri o branchi di cinghiali.
La Faragnana era tutta tagliata a terrazze, su ognuna delle quali le diverse famiglie di coloni o di proprietari terrieri, da generazioni, coltivavano viti, ciliegi, noci, castagne, peschi ed altro; su ogni terrazza sorgeva una “masseria” che prendeva il nome dalla famiglia che vi si era stanziata, che vi aveva costruito una casa colonica, una cantina interrata, “o’cellaro”( dove, in genere, si conservavano vino e salumi) il pozzo, il forno per il pane ed una stalla per le mucche, il mulo, il maiale e, se si era benestanti, il cavallo.
La casa colonica, che occupava proprio una di quelle terrazze e che appariva, nella incerta luce di quella livida alba, di un colore grigio sbiadito, apparteneva alla masseria di Don Antonio De Vita, un uomo nato come colono su quella terra, ma che, a costo di grandi sacrifici, ne era diventato proprietario. Antonio era un uomo ancora giovane, massiccio e solido come un secolare albero di noci, un uomo che amava la sua terra, il lavoro di agricoltore e la sua famiglia. Sua moglie, Nunziata, una donna dall’aspetto florido, molto semplice e molto religiosa, gli aveva dato due figlie: Amelia e Rita, ora, in quella fredda alba, stava ancora una volta per partorire, dopo aver perso, in precedenza, altri due figli dandoli alla luce. La poveretta ne aveva tanto sofferto da rimanere prostrata per mesi ed ora il nuovo parto faceva stare tutti col fiato sospeso.
D’un tratto il silenzio di quel freddo mattino fu rotto da un urlo che non aveva nulla di umano: era Nunziata che, fino a quel momento aveva sofferto silenziosamente, ma che adesso, al culmine del parto, aveva dato libero sfogo alle sue sofferenze. Antonio intanto, che nervosamente si era trattenuto con Fiore e Tanino, i suoi giovani aiutanti, nell’ampio tinello rischiarato dalla tremula luce di una lampada a petrolio, sentito l’urlo della moglie capì e balzò in piedi, pallido in viso e madido di sudore, gridando: “L’ha fatto! L’ha fatto! “.
Dall’interno della camera, dove regnava grande agitazione, qualcuna delle donne gridò:
“E’ mascolo, è mascolo!..”
All’esterno, tutto quel tramestìo svegliò i due setter che don Antonio utilizzava per la caccia, i quali cominciarono ad agitarsi, abbaiare e latrare. Dopo poco la porta della camera da letto si aprì e ne uscì Donna Rosa, la levatrice, impettita, raggiante e soddisfatta come un’antica matrona romana, con in braccio un fagottino, avvolto in una vecchia coperta di lana dalla quale uscivano striduli vagiti. Si avvicinò ad Antonio e gli consegnò il neonato dicendo:
“Donn’Anto’, è maschio, è sano e bello comm’ o’ sole!…..”.
La gioia di Antonio in quei giorni fu incontenibile: era nato finalmente un maschio, dopo tanto penare, un maschio che avrebbe perpetuato la famiglia De Vita, un maschio forte e sano come suo padre, come suo nonno, e come suo nonno si sarebbe chiamato Paolo. Bisognava battezzarlo subito e fare una grande festa. In pochi giorni furono avvertiti i parenti e gli amici, primo fra tutti il più caro, l’amico fraterno di sempre di Antonio: Don Nicola Tortora, proprietario dell’omonima masseria. Erano cresciuti insieme ed erano come fratelli, anche se dissimili nell’aspetto fisico e nei caratteri: tanto massiccio, austero, serioso e silenzioso Antonio, tanto mingherlino, scherzoso, allegro e ciarliero Nicola.
Per la verità, da un po’ di tempo, l’allegria di Nicola si era attenuata, ai suoi modi vivaci e chiassosi di una volta si era sostituito un atteggiamento pensieroso ed un aspetto alquanto accigliato. A caccia, la loro comune passione, sparava poco e rimaneva spesso dietro silenzioso, col capo chino, come preso da tormentosi pensieri. Era stato proprio ad una battuta di caccia, pochi mesi prima della nascita di Paolo, che Antonio, fermatosi ad attendere per l’ennesima volta che Nicola lo raggiungesse, gli chiese a bruciapelo:
• Nico’ ma se po’ sapè che tiene?..
• Niente, niente, Anto’, nunn’è niente!..
• Ma come niente!?.. Me pare ‘nu mulo: non ridi, non parli, ma che fai mi sfotti?..
Nicola non seppe nascondere all’amico la sua pena: lui e sua moglie non riuscivano ad avere figli, erano ormai sposati da sette anni e Immacolata, malgrado l’aspetto florido e rigoglioso, non era mai rimasta incinta. Inutili erano stati i ceri accesi e le preghiere a San Castrese, patrono del paese. Tutto ciò aveva logorato i nervi della povera Immacolata, che, ogni mese, al sopraggiungere del mestruo, non faceva che piangere e disperarsi. Peggio accadeva se si sapeva che qualche vicina o parente era gravida del terzo o quarto figlio.
• Anto’, a casa mia sono più i pianti che le risate… Non so nemmeno io che cosa fare! Immacolata si sta distruggendo e intanto figli non ne vengono…
• E questo è tutto?.. Ne Nico’, chissà che mi credevo!.. I figli vengono quando meno ci pensi, fa’ ‘na bella offerta a San Castrese e poi vedi se Immacolata non ti dà un bel figlio!
Ma figli non ne venivano e poco a poco Nicola ci si era rassegnato, abituato, ma anche intristito.
Quando aveva saputo della nascita di Paolo, però, era stato felice come una Pasqua, come se fosse nato a lui ed ora, alla festa del battesimo, nella quale lui era stato scelto come padrino del bimbo, se lo teneva in braccio, sorridente, sfiorandone ogni tanto il visino con la mano rugosa. Fu una festa indimenticabile, venne anche il Parroco, Don Giovanni, ed il vecchio Don Carluccio, che sapeva leggere, scrivere e far di conto, che suonò tutto il tempo la fisarmonica, tenendo tutti in allegria. Anche il tempo fu clemente: malgrado l’autunno inoltrato, non piovve e l’aria si mantenne fresca e piacevole fino a sera. Antonio e Nunziata gongolavano di gioia e tutti intorno a loro facevano festa. Erano venuti tutti: i fratelli e le sorelle di Antonio con le loro famiglie, il fratello di Nunziata con moglie ed i sei figli, amici, conoscenti, i vicini e perfino Don Carmine Casale, il più ricco e facoltoso proprietario della zona (con la moglie, gravida al settimo mese, e i due figli maschi, Ninì ed il piccolo Sandro, dei quali andava orgoglioso) che, per regalo al nascituro, aveva portato una catenina d’oro con appeso un piccolo crocifisso: un regalo importante, pesante, acquistato a Napoli, a via Toledo!
L’unico parente di Don Antonio che mancava era un suo cugino materno, Cosimo Vitale e sua moglie Filomena, la loro assenza però era ampiamente giustificata dal fatto che Cosimo, che per mestiere trasportava col suo grosso carro ogni genere di merci, in quei giorni, era impegnato a consegnare botti per il vino in provincia di Caserta.
A dire il vero Antonio non si era rammaricato più di tanto dell’assenza di Cosimo, tra loro non era corso mai buon sangue: Antonio rimproverava al cugino di bere troppo e di usare modi troppo bruschi e violenti con tutti, ma specialmente con la moglie, la povera Filomena, una donna dai capelli di un colore rosso caldo ed intenso, che, da ragazza, era stata di una notevole bellezza, ma che ora appariva visibilmente sfiorita; da tutti era definita una vera martire, costretta com’era a subire le aggressioni (anche fisiche) del marito. Inoltre Antonio non perdonava a Cosimo di aver venduto, per pochi soldi, tutta la terra coltivabile che aveva ereditato da suo padre, il defunto Don Gennaro Vitale, per fare il carrettiere, trasportando, tra Marano, Chiaiano, Napoli e dintorni, ogni tipo di merci, su quel grosso carro di legno, trainato da un castrato grigio dalle dimensioni colossali, acquistato proprio con il ricavato della vendita del terreno. Ecco perché Antonio, in fondo, era stato quasi contento di non vedere alla festa di suo figlio “…quella faccia verde di Cosimo”, godendosi, con tutti gli invitati, fino in fondo, la gioia di quel momento.
Solo Immacolata, in tutto quel frastuono di musica, danze ed allegria, era rimasta in disparte tutta la giornata, senza parlare e senza toccare cibo. Aveva parlato solo una volta, a Nunziata, quando questa si era appartata in camera da letto per dare latte a Paoluccio, lei era sopraggiunta nella stanza, aveva guardato per un momento e con dolore la tenera scena di maternità e, improvvisamente, slacciatosi il corsetto e mostrando i suoi voluminosi seni, aveva urlato a Nunziata:
“Il Padreterno che me le ha date a fare?..”
Ed era scappata via singhiozzando. Nunziata non raccontò mai a nessuno quel triste episodio, che le aveva fatto constatare quanto Immacolata stesse soffrendo della sua mancata maternità, fu da quel momento che Nunziata pose, proprio Immacolata, in cima alle sue preghiere.
La nascita di questo figlio maschio diede ad Antonio maggiore entusiasmo e vigore, ora sapeva di dover lavorare quella sua terra per poi lasciarla a Paoluccio, non sarebbe dunque finita divisa tra i futuri mariti delle sue due figlie, ma sarebbe rimasto appannaggio di un De Vita.
Gli anni immediatamente successivi alla nascita del figlio, per Antonio, furono un susseguirsi di stagioni di semina e di raccolto,
senza posa, riducendo al minimo i momenti di riposo e di svago, sacrificandosi con ogni tempo ed ogni clima. Fiore e Tanino, i suoi due aiutanti che erano cresciuti come figli nella masseria De Vita, ed avevano imparato tutto da Don Antonio, pur essendo di molto più giovani di lui, non riuscivano a stargli dietro. Ma tutta questa foga e questo entusiasmo di Antonio nascondevano anche un altro progetto che egli coltivava per suo figlio ed una sera d’inverno, fumando un sigaro accanto al camino acceso, mentre fuori Domineddio pareva aver dimenticato aperte le manichette della pioggia, egli lo rivelò a Nicola:
“Nico’, mio figlio non deve venire su ignorante come me, deve andare alla scola e imparare a leggere e fare i conti, così nessuno lo farà mai fesso!”
Anche per questo s’impegnò a lavorare di più e così i suoi sacrifici, i suoi sforzi furono premiati: a sette anni Paoluccio fu ammesso alla scuola elementare di Marano dove ogni giorno Tanino lo accompagnava col calesse che Don Antonio aveva acquistato di seconda mano da Carmine Casale, in cambio di una delle sue mucche migliori.
Fu proprio in quel periodo che accadde l’incidente.
Un pomeriggio di fine novembre Nicola Tortora era piombato alla masseria De Vita improvvisamente, chiedendo di Antonio e spaventando Nunziata:
• E’ in campagna Nico’, lo trovi là con Fiore e Tanino, ma è successo qualcosa?
• Donna Nunzia’, questo è il giorno più bello della mia vita: Immacolata è incinta!..
Raggiante era corso in campagna a comunicare la notizia ad Antonio che, per poco, per l’entusiasmo, non era caduto dalla scala su cui era salito per curare una vecchia pianta di ulivo.
Per la gioia del lieto evento decisero che il giorno dopo lo avrebbero dedicato interamente alla caccia, la loro grande passione, nessuno dei due avrebbe lavorato.
All’alba, infatti, erano già in cammino per la selva verso la “Recca”, in compagnia di Fiore e dei due setter di Antonio. Ad un certo punto, giunti ad una larga radura, notarono che i cani si agitavano, avendo fiutato e puntato una preda, proprio davanti a loro, dove la boscaglia tornava ad essere un’unica macchia buia. Non riuscivano a vedere bene di che si trattasse, anche perché la luce, a quell’ora del mattino, era troppo incerta per distinguere cosa ci fosse e chi si agitasse in quel nero groviglio di rami e di sterpaglie. All’ordine di Antonio, i cani si lanciarono nel buio del fogliame e dopo poco, tra i loro latrati, si distinsero chiari i grugniti disperati ed aggressivi di uno o forse due cinghiali. Nicola, Fiore ed Antonio si prepararono a far fuoco, disponendosi a semicerchio. Il tramestio continuava senza che nessuna delle bestie uscisse allo scoperto. Ad un certo punto i tre decisero di dividersi: Fiore sarebbe rimasto nello spiazzo, mentre Nicola da un lato e Antonio dall’altro, avrebbero tentato di aggirare la macchia. Così Antonio si inoltrò sul lato destro; improvvisamente si accorse che la lotta tra le bestie si era interrotta ed era ritornato il silenzio. Avanzò con maggiore cautela e alzò il cane della sua doppietta, pronto a sparare al minimo movimento; intanto intorno a sé il buio era quasi totale, non riusciva a distinguere nulla, si rese conto solo che, ad ogni passo, il terreno diventava sempre più sconnesso, pieno di ciottoli e massi. Ad un tratto, davanti a sé, sulla sinistra, avvertì un lungo guaito di uno dei suoi cani, un guaito di dolore, senza alcun dubbio, Antonio, abbandonò ogni prudenza e si precipitò di corsa là, dove il suo cane aveva lanciato quel lamento, ma riuscì a fare solo pochi passi, perché si sentì mancare il terreno sotto i piedi; perdendo l’equilibrio, si lasciò sfuggire da mano il fucile, cercò disperatamente di aggrapparsi ad un arbusto ma gli rimasero tra le dita solo poche foglie. Urlando per il terrore, cominciò a scivolare, scivolare verso il basso, sempre più giù, cercando di puntellarsi e di frenare quella che, ormai lo aveva capito, era diventata una terribile ed irrefrenabile caduta nel buio di qualche burrone. Arrivò fino a valle dopo una serie di giravolte e capriole su se stesso. L’ultima cosa che sentì fu un impatto violentissimo ed un dolore lancinante alla gamba ed alla spalla destra, poi più nulla, il buio ingoiò improvvisamente ogni cosa ed ogni sensazione, anche quel dolore insopportabile.
Fu il freddo a svegliarlo, dopo diverse ore, doveva essere rimasto svenuto per molto tempo in fondo a quello che, probabilmente, era un vecchio canalone utilizzato, forse, qualche secolo prima, per far defluire l’acqua del fiume “Starza” ed irrigare qualche campo, un tempo coltivato lì vicino.
Antonio era disteso supino, in una posizione del tutto innaturale, cercò, quindi, di muoversi e di sistemarsi meglio, ma non ci riuscì, il dolore alla gamba destra, al minimo movimento, fu talmente forte da farlo desistere da ogni tentativo. In compenso riusciva a muovere il lato sinistro, pertanto cercò di puntellarsi su quella gamba per trovare una posizione più comoda, ma ogni movimento comunque gli provocava dolori insopportabili. Spossato, avvilito, si abbandonò di nuovo e cercò di guardarsi attorno per capire bene dove fosse finito, ma capì solo che era notte e che, se non lo avessero trovato per tempo, sarebbe sicuramente morto.
Cominciò a tremare dal freddo e dal terrore che lo pervase:
“Morto?… No! Non posso morire proprio adesso! E chi ci pensa alla masseria, alla famiglia, a Paoluccio? Tutti quei progetti…Tutto finito, tutto? No, no e poi no!..”
Antonio si scosse dal torpore che ormai lo assaliva, deciso a vincere quella battaglia contro la morte. Si rese conto che doveva rimanere sveglio ad ogni costo e si costrinse a pensare per reagire, per salvarsi. Cercò nella tasca della giacca che indossava e vi trovò la scatoletta di zolfanelli insieme ad un mezzo sigaro. Raccolse tutte le sue forze e, pur non vedendo, tastò con la mano sinistra il terreno in cerca di qualcosa che potesse essergli utile e la trovò: afferrò con la mano sinistra, imprecando per il dolore, un po’ di sterpi ed una grossa manciata di foglie secche, ne fece un mucchietto vicino a sé, tirò fuori uno zolfanello e lo accese dando fuoco a quella piccolissima brace. Il calore del piccolo fuoco gli diede coraggio, cominciò a soffiarvi sopra per alimentarlo ed a cercare altri sterpi e foglie. Riuscì così a fare un piccolo falò che lo riscaldava e nel contempo illuminava un po’ quel luogo tetro e desolato.
In quel momento capì che non sarebbe morto, che ce l’avrebbe fatta a resistere, a venirne fuori, a sopravvivere.
Nicola, intanto, dopo aver cercato Antonio, insieme a Fiore, era tornato indietro a chiedere aiuto e, per tutta la giornata successiva, insieme a Fiore, a Tanino e a qualche altro buon amico, aveva battuto tutta la selva circostante, chiamando a viva voce il nome di Antonio, potendo, però, utilizzare solo uno dei setter, poiché l’altro era rimasto seriamente ferito nell’aggressione subita dai cinghiali.
Sconfortati, a sera, Nicola e gli altri erano tornati alla masseria De Vita, dalla povera Nunziata che appariva disperata. Nicola, affranto, le aveva detto:
“Tutta colpa mia…non dovevo lasciarlo solo…ma state tranquilla, donna Nunzia’, ve lo trovo Antonio e ve lo riporto sano e salvo. Tanto lo so ch’è vivo !..”
Le ricerche di Antonio erano andate avanti per due giorni, ma senza alcun risultato e ormai si disperava di poterlo ritrovare. Solo Nicola non si rassegnava all’idea di perdere così l’unico amico che avesse, non si arrendeva, continuando, tenace, le sue ricerche.
Alla fine, all’alba del terzo giorno, decise di riprendere le ricerche, insieme a Fiore ed a Tanino, partendo proprio dal luogo dove Antonio era sparito. Lo aveva sentito urlare proprio là, in quel folto fogliame, dove ora, lentamente e con prudenza, si addentrava, setacciando palmo a palmo tutta la zona circostante. D’improvviso vide e capì.
C’era una specie di piccolo sentiero sulla destra, che poco si distingueva, che però portava ad uno scalino, al di là del quale si apriva, sul fianco della collina, un vero e proprio strettissimo strapiombo con un salto altissimo. Era un vecchio canalone abbandonato, di cui pochi erano a conoscenza. Da quel punto più alto Nicola chiamò ad alta voce il nome di Antonio più volte, ma gli rispose solo il fruscio delle foglie degli alberi.
“ Lasciate stare, Don Nico’, è tutto inutile, se Don Antonio è caduto da questa altezza non si è potuto salvare” gli disse Fiore tirandolo via di forza per un braccio da quel punto così alto e pericoloso.
Antonio, intanto, dal fondo del canalone aveva sentito Nicola chiamarlo, ma, stremato dal freddo e dalla sete che lo tormentava, non aveva avuto la forza per gridare e chiedere aiuto. Capì, però, che, se non avesse risposto a quel richiamo, Nicola si sarebbe rassegnato e per lui non ci sarebbe più stata salvezza. Raccolse tutte le sue forze, si puntellò sul braccio sinistro, respirò profondamente e con tutta la forza che gli rimaneva gridò:
“Aiutami Nico’, sono qua!”
Nicola si divincolò dalla presa di Fiore: aveva sentito qualcosa, un flebile lamento, lontano, lì in fondo a quel nero burrone, sì, era sicuro, Antonio era proprio lì, ne era certo. Così, tanto insistette che, con una fune, si fece calare da Fiore e Tanino giù, sempre più giù nel canalone ed in fondo, quasi ai piedi della collina, lo trovò.
Riportare Antonio alla masseria fu una vera impresa: con l’aiuto di buoni amici, lo si fissò su di una specie di barella di fortuna, costruita sul posto, con poche assi di legno; poi, con le indicazioni di Don Carluccio, vecchio esperto dei luoghi, lo si portò, a braccio, fino a valle del burrone, lì si seguì uno stretto sentiero che quasi si confondeva col vecchio letto asciutto di un fiume e, dopo mezza giornata di lento e faticoso cammino nel folto della selva, si risalì una piccola altura per giungere alla località detta “San Rocco”, dove la strada, che si apriva pianeggiante e sterrata, conduceva al paese di Marano. Lì Antonio fu caricato su un calesse e portato a casa del Dottor Saverio Pagano, giovane medico condotto della zona. Questi, dopo averlo visitato, fu lapidario:
• Ringrazia il Signore di essere vivo, Anto’, certo, la gamba è persa e nessuno te la può più ricucire, ma già è tanto se hai salvato la pelle. Un periodo di riposo e torni come nuovo!..
• Sì – gli fece eco Antonio – come nuovo…ma zoppo!
Infatti Antonio non recuperò più l’uso della gamba destra, rimase storpio, costretto a reggersi su di una stampella per fare qualche passo. Certo, continuò a dirigere il lavoro di Tanino e Fiore nella masseria, ma niente più caccia e tutta la sua esistenza cambiò completamente fisionomia. Ora era uno zoppo che affannava per ogni movimento, che si muoveva sul dolore e che resisteva poco a stare in piedi, cercando in fretta una sedia dove sprofondare pesantemente.
L’unico conforto per lui era vedersi sgambettare attorno il figlio Paoluccio che, intelligente e curioso di tutto, gli faceva mille domande sul bestiame o sul raccolto o sui segreti della caccia che, sin da ora, lo affascinava. Teoria, certo, solo teoria: Antonio non gli avrebbe mai mostrato come acquattarsi nel fogliame per vedere levarsi in volo, dai piccoli stagni, le folaghe o distinguere il verso delle beccacce da quello delle starne ed in quale preciso momento tirare il grilletto per colpire la preda, con la rosa dei pallini della sua doppietta.
A tutto questo provvide però Nicola, che non smise di andare a caccia, malgrado l’incidente occorso al suo amico, anzi, cominciò a portarsi dietro Paoluccio, appassionandolo ai segreti di quella pratica antichissima. Ciò servì a rinsaldare sempre più i rapporti tra il ragazzo ed il suo padrino, il quale si era come convinto di avere due figli e non una soltanto. Infatti, Immacolata aveva dato alla luce una bimba bellissima, bionda, dall’incarnato roseo, che i genitori avevano battezzato col nome di Angela, poiché, dicevano, come un vero angelo, aveva, con la sua nascita, riportato il sorriso nella famiglia Tortora.
Insomma Nicola considerò sempre Paoluccio come un figlio, quel figlio maschio che egli aveva sempre desiderato, ma che si era rassegnato a non avere mai.





